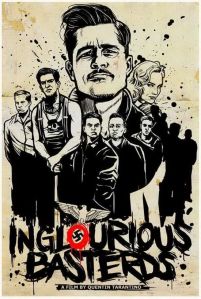Ho letto più volte un noto (in Italia) critico dei giardini, di cui non faccio il nome (Guido Giubbini, presidente del comitato scientifico della celebre (in Italia) rivista “Rosanova”), sostenere che esiste un “giardinaggio al femminile”.
A questo punto il ventaglio delle domande si apre: se esiste un giardinaggio al femminile, esiste anche un giardinaggio al maschile?
E se questo vale per maschi e femmine, vale per gay, lesbiche, trans, bisex, tavestiti, per BDSM, per i fetiscisti, quelli che si travestono da mobili o che si fanno fare la pipì addosso?
E per ognuno di questi generi o transgeneri, quale sarebbe -di grazia- la tipologia di giardinaggio praticata?
Speriamo che l’illuminazione non tardi a venire.
Ma mi domando, non è che poi si rimane sul classico, nel dualismo maschio/femmina, con la consapevolezza di scatenare le ire della gente? Al massimo si scrive “giardiniere 1 – giardiniere 2” tanto per metterci una pezza?
O ancora “giardinaggio al femminile” significherebbe che c’è un modo di fare giardinaggio che sarebbe quello giusto, quello fatto dai maschi, e un altro modo, meno elevato, per così dire, che è quello delle femmine? Un filino subdolo, no? Sono malpensante? Me lo auguro.
Ma attendiamo e per il resto mistero della fede giardinicola.Tanto siamo sotto Natale.
Non è la prima volta che sento queste cose, e purtroppo per buona parte della mia vita ci ho anche creduto. Una volta una mia insegnante di illustrazione, di cui non faccio il nome (Valeria Ricciardi, tecniche di base, Istituto Europeo di Design, anno Domini 1991), disse che si poteva capire benissimo se un disegno era fatto da un uomo o da una donna.
Il famoso “conto alla femminina” (cioè il calcolo aritmetico per dare il resto) è più che automatico per tutti ma viene declassato come elementare.
Un ingegnere giardiniere che spero legga e si riconosca, disse che l’ingegneria non è per il cervello delle donne, e che le sole donne iscritte a Ingegneria erano “maschi” (dunque non scopabili).
 Tornando al giardino e al giardinaggio (che sono comunque due cose diverse), mi starebbe benissimo se con “giardinaggio al femminile” si volesse intendere una ricapitolazione storica e sociale di come alle donne di buona società, cioè quelle che potevano permettersi un giardino, non fosse consentito piantare e zappare poiché attività disdicevoli, e di come alle donne fu permesso di lavorare in giardino, blandamente, con i guanti e per piccoli lavoretti di piantagione di fiori, bulbi o semine a spaglio, solo a metà dell’Ottocento, quando l’offerta di piante in vaso era tale da dover smaltire una enorme quantità di merce e si rese necessario raddoppiare il mercato degli acquirenti, inserendo anche la clientela femminile. Abbiamo molte testimonianze dai cataloghi di vendita per corrrispondenza e dagli opuscoli dedicati al pubblico maschile e femminile (all’epoca i gay venivano ancora frustati a sangue e mandati nei campi di lavoro, figuriamoci il giardino).
Tornando al giardino e al giardinaggio (che sono comunque due cose diverse), mi starebbe benissimo se con “giardinaggio al femminile” si volesse intendere una ricapitolazione storica e sociale di come alle donne di buona società, cioè quelle che potevano permettersi un giardino, non fosse consentito piantare e zappare poiché attività disdicevoli, e di come alle donne fu permesso di lavorare in giardino, blandamente, con i guanti e per piccoli lavoretti di piantagione di fiori, bulbi o semine a spaglio, solo a metà dell’Ottocento, quando l’offerta di piante in vaso era tale da dover smaltire una enorme quantità di merce e si rese necessario raddoppiare il mercato degli acquirenti, inserendo anche la clientela femminile. Abbiamo molte testimonianze dai cataloghi di vendita per corrrispondenza e dagli opuscoli dedicati al pubblico maschile e femminile (all’epoca i gay venivano ancora frustati a sangue e mandati nei campi di lavoro, figuriamoci il giardino).
Sarebbe infatti interessante capire come le necessità hanno influito sull’emancipazione della donna in giardino, specie in America, dove tutto è avvenuto molto rapidamente. Alle donne erano affidati il backyard garden e la manutenzione delle erbe curative, l’orto e il frutteto. Nelle zone del Texas molte donne diventavano curanderas, cioè guaritrici.
Nella Vecchia Europa le cose procedevano molto più lentamente: ce lo racconta Elizabeth von Arnim, ce lo racconta E.M. Forster, ma anche George Eliot, la stessa Sackville-West.
Quando la storia del giardino fu invasa dalle varie femmine giardinicole (Jekyll, Crowe, Hobhouse, Taverna, Verey, Thaxter, Fish e compagnia cantante), il mercato era già pronto, e dunque lo era la società. Via libera alle femmine piantatrici di bulbi che riempiranno di fiori i loro giardini e di soldi le nostre tasche!
Se Emma poteva solo cucire sul prato, ritrarre le rose fiorite e le sorelle Dashwood passeggiare tra le folly, un secolo dopo la Signora Miniver riusciva a mettere le mani nella terra, ma l’unico rapporto che Rebecca de Winter aveva con i fiori era la loro disposizione in vaso. Le classi sociali in questo erano estremamente prescrittive.
Occorre la Seconda Guerra Mondiale, il victory garden, o qui in Italia “orticello di guerra”, il lavoro delle donne in fabbrica e le lotte femministe per ottenere una equipollenza della donna in giardino, che tuttavia non è reale ma -a dir dell’uomo- limitata dalla minore forza e resistenza fisica. Naturalmente tutte le donne che fanno giardinaggio sanno di poter svolgere anche i lavori pesanti (più che un uomo basterebbe solo un’altra persona come aiuto, sia essa maschio, femmina o transgender). D’altra parte la presunta debolezza della donna non coincide con la sua storica posizione di bestia da soma e animale da lavoro: basti pensare alle mondine, alle gelsominaie, alle raccoglitrici di olive, alle donne con cercine e pesanti ceste sulla testa, o in tempi moderni, donne neanche più giovani che scaricano camion di frutta.
Ciò che io temo nella frase “giardinaggio al femminile” è un pretestuoso tentativo di dimostrare, con tendenziosità, che le femmine della specie si dedichino alla coltura del fiore più che della pianta, agli accostamenti tra fiori e colori, alle composizioni in vaso, anche se transitorie come la loro memoria, alle fioriture in massa perché di più è bello, ai colori azzurri e bianchi, rosa e bianchi, rossi e bianchi, alle piante con foglioline delicate e soffici, alle rose, alle rose con le perenni, alle rose con le annuali, alle rose con le graminacee, alle rose con le rose. Insomma che non siano troppo attente alla qualità dei verdi, alle loro sfumature, agli accostamenti tra fogliami, al giardino senza fiori, alle piante legnose, agli alberi, ai prati, alle attrezzature, alle motoseghe, e in genere a tutti i lavori di manutenzione come il tutoraggio dei rami o la potatura delle siepi. Inoltre si sa che le femmine hanno un odio genetico per tutte le piante a spada, quindi tra la Yucca e Satana è meglio Satana, per i cactus troppo grandi (forse perché si spaventano delle forme falliche, poverette), per le palme e gli alberi esotici perché non capiscono un cazzo se una pianta è rara o no. Termini come “monocarpico” o “cleistogamo” non fanno parte del loro vocabolario, che è invece pieno di aggettivi su come descrivere un colore, una foglia, l’aria del mattino, la luce del sole, la pace, il silenzio, il fruscio del vento, la lettura, la tazza di tè. Aspetti tecnici e pratici, quali la botanica, l’entomologia e le sue applicazioni, le patologie, la coltivazione di piante “utili”, sono del tutto estranee alla mente femminile.
Per la femmina il giardino si risolve tutto in letture, pensierini, citazioni, poesiole, consigli su come accostare questa e quella pianta, ghirlande e disegnini.
Per la cronaca, questi l’hanno fatti due maschi.

Ippolito Pizzetti, Canon Ellacombe, Goethe, lo stesso Giubbini, Marco Martella, Richard Mabey, Čapek, Borchardt, Pindemonte, Osti, Trevisan, Delerm, Eden, Peregalli, Monty Don e per finire Pejrone, Pagani e Perazzi, hanno messo nei loro libri oltre a consigli pratici su fiori e colori, una buona dose di poesia, letteratura, citazioni e umorismo. Alcuni non esenti da mielosità dozzinale e appiccicaticcia.
Mentre non c’è prosa più asciutta, divertente e interessante di quella di Andrea Wulf (femmina) o più compassata e accademica di Annalisa Maniglio Calcagno. Beatrix Potter è stata una giardiniera assai pratica e senza illusioni di grandiosità, e credo che nessuno abbia scritto una storia dei giardini così dettagliata e ricca come Marie Luise Gothein.
I consigli per gli accostamenti di colori ce ne dati anche troppi Christoper Lloyd con la serie dei libri per “giardinieri avventurosi” (che diciamocelo, sono un po’ commerciali), e pensieri sparsi e digressioni sono il cuore delle “passeggiate botaniche” di Rousseau.
Insomma, pare che il maschio della specie non sia esente da “scivoloni nel giardinaggio al femminile” (cit.).
Domanda: saranno gay, trans, bi, tri? Oppure, no, dico, la butto lì, non sarà che non esiste un giardinaggio maschile e uno femminile, e che è tutto un fatto storico e culturale, cioè appreso?
Ma già all’orecchio… Lo sentite? “Giardinaggio al femminile”. Come una brutta copia di qualcosa. Una versione adattata per piacere a un certo pubblico, come Jack London che arriva in Italia in versione ridotta illustrato per bambini. Facciamo La Sirenetta a cartoni animati, ma la facciamo finire bene! Facciamo un giardino per femmine, perché esse non sono in grado di comprendere il vero giardino (intanto però gli vendiamo i fiori). E poi, si sa, la brodura mista migliore l’ha fatta Sir Lawrence Johnston, un maschio. I grandi paesaggisti sono tutti maschi, le femmine al massimo fanno l’aioletta.
Ma certo, Caruncho, Barragán, vuoi mettere?
Vuoi mettere che solo dagli anni Ottanta alla donne è stato consentito di avere una visibilità professionale? Vuoi mettere che prima una donna difficilmente poteva iscriversi ad Architettura, e difficilmente sarebbe stata considerata una professionista pari a un uomo? Vuoi mettere che nella storia le donne hanno sempre lavorato ai margini, con talenti enormi che dovevano rimanere imbrigliati nelle possibilità sociali dell’epoca? Vuoi mettere che -come scrisse Virginia Woolf- nella storia la firma “Anonimo” coincide con il nome di una donna?
Ovviamente oggi è tutto diverso, e le femmine possono finalmente fare le architette del paesaggio, ma che risultatati vuoi che ottengano? Boh, robetta, giardinetti pieni zeppi di fiori… Ad esempio questo:
o questo…
Insomma, senza andare a scomodare i grossi nomi di Beatrix Farrand, Kathryn Gustafson, Paola Viganò, o la buonanima di Zaha Hadid, di architette ce ne se sono, oggi, eccome.
E a volte mettono tanti fiori nei giardini che progettano, a volte no. Di certo non credo che siano interessate a ciò che i maschi pensano su come loro interpretano il giardino. Credo siano più interessate a guadagnare e fare il loro lavoro, esattamente come i colleghi maschi.
Qualche link utile:
Ranker.com – Architette illustri
Ranker.com – botaniche illustri
Lista di architette su Wikipedia
Sette donne vincitrici di un premio per l’Architettura del Paesaggio
Andrea Cochran
Cheryl Barton Studio
Mia Lehrer e associati
Katherine Spitz
Pamela Palmer
Lauren Meléndrez